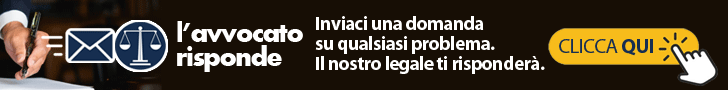Mobbing. Il reato di maltrattamenti in famiglia anche in azienda
Il mobbing torna alla ribalta con una sentenza della Cassazione penale, la numero 53416/14, depositata il 22 dicembre che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene utile portare all'attenzione per i rilevanti profili giuridici e le conseguenze in termini di maggiori tutele per i lavoratori, rappresentati con la decisione in questione.
Per i giudici di legittimità, infatti, non conta il numero dei dipendenti in azienda, ma la qualità delle condotte persecutorie poste in essere dai vertici societari ai fini della rilevanza penale del mobbing. Nè esclude la configurabilità il fatto che la vittima sia un addetto che ha un’anzianità di servizio non trascurabile e avrebbe sopportato a lungo le vessazioni dei capi.
Per gli ermellini, anche in un’azienda che non è una bottega artigiana ma annovera ben venticinque addetti, infatti, può sussistere il reato di "maltrattamenti in famiglia" di cui all'articolo 572 Cp a carico dei vertici societari per la mortificazione e l’isolamento del singolo lavoratore. Ai fini della configurabilità del delitto in questione rileva la sussistenza in azienda di un rapporto «para-familiare», sul vecchio modello artigiano-apprendista, che ben può configurarsi quando ad esempio c’è un “padre-padrone” che gestisce i rapporti in modo del tutto autoritario nell’ambito di un rigido schema relazione “supremazia-subalternità”.
Con la decisione in commento, i giudici dalla sesta sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’appello contro l’assoluzione pronunciata in appello in favore del presidente e dell’amministratore delegato della società riformando la precedente decisione di primo grado.
Per i giudici di Piazza Cavour la motivazione del provvedimento che aveva assolto i vertici aziendali risulta viziata sotto diversi profili: anzitutto l’esclusione della configurabilità del reato decisa sul mero rilievo del numero di addetti, che pure non è la dimensione delle microimprese sotto i dieci dipendenti.
Tale rilievo deriva dal fatto che risulta sempre necessaria da parte del giudice una valutazione sulle effettive dinamiche delle relazioni fra il titolare e dipendenti, anche se nelle imprese più grandi i rapporti fra dirigenti e sottoposti tendono a essere più superficiali e spersonalizzati. In definitiva, rileva l’eventuale stato di soggezione da parte del dipendente che si ritiene perseguitato.
A nulla vale quanto affermato dalla difesa, secondo cui le vessazioni lamentate dalla dipendente siano il trattamento riservato per prassi alle lavoratrici che tornano dalla maternità (prassi invero molto triste). Né giova sostenere che il rapporto fra l’azienda e la parte offesa dal reato vada avanti da lungo tempo: l’atteggiamento dittatoriale del titolare può azzerare ogni anzianità di servizio o mansione. In tal senso risulta inconferente il rilievo secondo cui la parte offesa abbia sopportato a lungo le condotte discriminatorie: il dipendente potrebbe esservi stato costretto perché ha bisogno di lavorare e non ha alternative professionali.
In ultimo, la configurabilità del reato non può essere negata in base alla circostanza secondo cui la lavoratrice abbia denunciato il mobbing alla procura della Repubblica, al sindacato e ai giornali. E ciò perché è impossibile riconoscere l’esclusione ex post del delitto per il fatto che la vittima abbia azionato tutti gli strumenti di reazione in suo potere per opporsi alla prevaricazione e ottenere la persecuzione delle condotte patite. Parola al giudice del rinvio.